da www.primadanoi.it
Infermieri del pronto soccorso costretti ad assistere i pazienti con il cappotto. Interi reparti ancora nei container. Delicate apparecchiature all’aria aperta. E una igiene che, giocoforza, a volte e’ quel che e’.
Stiamo parlando dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Un piccolo gioiello, fino al 5 aprile scorso.
Nuovissimo solo perché inaugurato nel 2000 ma che ha avuto una gestazione problematica e trentennale.
E oggi «siamo come a fine maggio», dice un’infermiera.
Cioe’ in piena emergenza. Alle porte dell’inverno. Come se tutti questi mesi fossero passati invano.
Siamo andati a farci un giro in quelli che furono, e in quelli che sono, i locali di uno dei nosocomi più moderni della nostra regione ma che ha subito numerosi danni in seguito al sisma del 6 aprile.
Reparti che oggi riescono ad andare avanti solo grazie alla dedizioni dei sanitari, mentre tutt’intorno sembra di essere ancora in piena emergenza sisma.
«Sono tornata subito al lavoro dopo l’influenza»: a parlare e’ Rosangela Costantini, infermiera del nucleo trasfusionale.
La incontriamo mentre porta due scatoloni pieni di sacche, vestita con piumino e cuffia.
Un reparto, il suo, in condizioni pessime dal punto di vista funzionale.
«Mi sono ammalata durante una notte di pioggia, mentre dovevo portare qua e la’ alcune sacche di sangue».
Perche’ questo reparto, oggi, e’ diviso in tre parti: un container nel quale vengono effettuate le analisi, un altro per le trasfusioni, e un’altra parte («il bunker», come lo definisce Rosangela), dove ci sono i frigoriferi per lo stoccaggio delle varie sacche.
«Quando ci sono le emergenze, mica si ha il tempo di coprirsi… E alla fine ci si ammala».
Strumentazione da migliaia di euro sono sistemati in una piccola rientranza della struttura, protetti da assi di legno sistemate alla bisogna, con un’apertura ai quattro venti.
«Vedi questa? – ci dice – e’ un’apparecchiatura per analisi particolari. La dobbiamo coprire con un lenzuolo perche’ se ci va la polvere diventa inutilizzabile».
«Nel container delle trasfusioni, la mattina, ci sono i pazienti, gli infermieri, i dottori: non ci entriamo», continua.
Pazienti a volte molto debilitati costretti a camminare tra le sferzate del vento di montagna.
Per ogni singola operazione, il personale sanitario deve entrare e uscire da queste strutture temporanee, con i rischi facilmente immaginabili per la loro salute e quella dei pazienti.
«Poi qualcuno deve portare tutto in reparto, al freddo», aggiunge.
Poi c’e’ la sala di terapia intensiva e nella stanza affianco, la sala per i parti cesarei.
«A volte arrivano persone in fin di vita che hanno vomitato, o con le feci addosso. Dall’altra porta, escono i bambini».
Stavolta a parlare sono Antonella Liberatore e Grazia Di Francesco, rispettivamente caposala del blocco operatorio e infermiera di rianimazione.
Reparti che devono la loro vita a quel personale sanitario che, fin dal 6 aprile, si e’ sacrificato con turni massacranti. Ma lavorare in queste condizioni non e’ il massimo né per i dipendenti né per i pazienti.
«Le condizioni igieniche? Noi ce la mettiamo tutta, ma alla fine sono le strutture che sono quelle che sono – dice Grazia – Nella terapia intensiva normale c’e’ un corridoio dello sporco, dove cioe’ chi deve entrare si lava e si cambia. Qua, come vedi, non c’e’».
No, non c’e’.
La gente entra ed esce, perche’ non potrebbe essere altrimenti.
Ospitati in una stanzetta in cui bisogna mettersi d’accordo per passare, i pazienti in rianimazioni distano meno di due metri dalla sala d’aspetto del pronto soccorso.
Se chi attende ha una qualche malattia infettiva, Dio solo sa cosa potrebbe accadere.
Una lettiga deve uscire: un’impresa in mezzo a tante persone costrette in spazi che non ci sono.
Una tracheotomia?
Oggi non si può. Troppo scarsa l’igiene.
«Nella saletta non abbiamo neanche l’areazione. Abbiamo dovuto lavorare tra odori tremendi. E come facciamo poi a disinfettare la porta? È di legno, non si può».
Il pronto soccorso e’ ancora ospitato in una struttura di plastica, con pavimento in legno.
La notte fa freddo.
È L’Aquila.
E tra i pazienti gli infermieri devono girare con il cappotto.
«Il problema grosso sono i posti letto», ci dice Antonella Liberatore, che e’ anche animatrice del comitato cittadino per la difesa del San Salvatore.
«La gente pensa che i letti a disposizione siano effettivi, ma non e’ vero».
Prima del sisma i letti erano 460, oggi circa 130, di cui più della meta’ per la riabilitazione.
«Oggi ci sono anche tanti operai che lavorano in citta’ – fanno notare – meno male che non e’ ancora successo nulla».
Le sale operatorie?
Da spavento.
Se prima del sisma erano dieci, oggi sono quattro, di cui due per i piccoli interventi, una per i cesarei, e un’altra all’interno dell’ospedale del G8, dove a volte i dottori devono stare piegati sennò sbattono la testa.
Se prima in terapia intensiva si potevano accogliere otto persone, oggi solo due più un’emergenza. «Non abbiamo neanche una centralina per controllare i pazienti – ci spiegano – quindi dobbiamo sempre controllarli a vista».
Girando per la struttura, sono decine gli uffici ancora accolti in tende o in container, con i militari che presidiano l’entrata puntellata di quello che fu il pronto soccorso.
La neve, per fortuna, non e’ ancora arrivata.
Tutto fermo come fosse maggio. Invece siamo a novembre e sono passati sette mesi dal sisma.
Ma a vedere il San Salvatore non sembra.
Alessandro Consalvi



















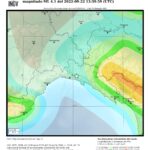



 6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.