Leggi anche la prima parte e la seconda parte.
Sabato sera ci ritroviamo tutti al Bar del Corso: quando arrivo – gli altri mi stanno già tutti aspettando – una cover band dei Dire Straits, nello spiazzo antistante al locale, sta suonando Love over gold; una ventina di persone ascoltano e applaudono poco convintamente. “Non è male – dice Gianmarco mentre stiamo bevendo un caffè – ma a me dopo un quarto d’ora pure Mark Knopfler m’ammorba: intendo l’originale. Figurémose l’imitaziò”. Sentenza inappellabile. Ci alziamo con destinazione Piazza Duomo, ma per arrivarci dobbiamo sgomitare un po’ in mezzo ad una piccola folla ammassata davanti all’entrata di uno di quei classici lounge bar dal gusto vagamente pacchiano, e che, se possibile, è ancora più fastidioso del solito, alla vista, trovandosi di fronte ai portici di Corso Vittorio Emanuele II, i cui pilastri se ne stanno impacchettati tra funi metalliche e puntellamenti di legno. Arrivati in Piazza Duomo, troviamo un altro gruppo che sta suonando su una palco di modeste dimensioni, ma ben attrezzato, con illuminazioni e fonico: si direbbe tutto abbastanza professionale, se i poveri musicisti non si vedessero costretti, per ridestare l’entusiasmo dei pochi spettatori, a passare, in rapidissima successione, dagli ACDC alla Bandabardò a Quant’è bellu lu primm’amor, stornello popolare abruzzese rigorosamente eseguito in versione sconcia. Battiamo le mani a tempo per qualche minuto, poi decidiamo di andare a Piazza Regina Margherita, dove una nostra amica ci ha invitato al suo brindisi di compleanno. La serata è un po’ così: vive di lenti arenamenti e di continue ripartenze.

Quattro Anni Dopo (di Marta Zollino)
Mentre risaliamo il Corso, siamo costretti a fermarci ogni manciata di metri per salutare amici e conoscenti che incontriamo: una stretta di mano, un abbraccio, un rapido scambio di battute. È un capoluogo di regione con quasi settantamila abitanti, L’Aquila, ma forse sarebbe più giusto considerarlo come un grande popoloso paesotto, una parrocchia con tante chiese (la tradizione vuole che siano 99) e dai confini dilatatissimi: se si stendesse un organigramma dell’intricata ragnatela di amicizie di tutti gli Aquilani, ci si accorgerebbe che in effetti sarebbe improbabile prevedere che, incrociandosi due gruppi di cinque o dieci persone ognuno, non ci fossero tra loro almeno due cugini alla lontana, due vicini di casa o d’ufficio, due compagni di scuola, di conservatorio, di piscina, di pattinaggio, di corso di acquerelli. Prima del terremoto, abituati alla stabilità di quei rapporti, alla ricorrenza di quelle facce, si finiva spesso per non dare troppa importanza agli incontri fugaci del sabato sera; ma da quando la devastazione del 6 aprile, e l’idiozia urbanistica della successiva emergenza, sono arrivate a sparpagliare quartieri e destini, a recidere relazioni e consuetudini, avverti il bisogno, quasi l’urgenza, di non lasciar sfibrare definitivamente i fragili legami che ancora – ancora per quanto? – ti uniscono a quelle persone. È un costante sforzo di aggiornarsi, di riavvicinarsi all’altro seppur per pochi istanti. Siete rientrati? Che lettera v’hanno dato? Dove v’hanno mandati? Per quanto tempo?[1] Erano queste le domande più frequenti nei messi che seguirono il 6 aprile 2009, formulate con il nuovo linguaggio del dopoterremoto, saturo di tecnicismi aspri e di ingegnose volgarizzazioni. Poi, con il passare del tempo, a quelle domande ne sono subentrate alcune nuove, inevitabilmente connesse alle lente, fangose procedure della ricostruzione. Ma il rinnovo di quell’infelice repertorio di domande, e del gergo utilizzato per esprimerle, è in realtà avvenuto solo in parte: ché anzi, proprio constatando come molte di esse persistano ancora, perlopiù immutate a distanza di oltre quattro anni, nei discorsi degli Aquilani, si può percepire la stagnazione della città. E infatti mi ritrovo a chiedere, ad un ragazzo che frequentava la mia stessa palestra e col quale – facebook a parte – non avevo contatti da almeno un anno, per quando è prevista la fine dei lavori di ristrutturazione del suo condominio, che sapevo imminente. “Non la tieni ‘na domanda di riserva?” – mi risponde lui.
Pur impiegando qualche minuto più del previsto, dunque, arriviamo in Piazza Regina Margherita. Così, almeno, viene indicata dalle targhe in pietra appese ai muri. Per tutti, però, quella è “la piazzetta deju Boss”. Ju Boss è una storica cantina aquilana: storica nel senso che ha ormai quasi un secolo di vita alle spalle. La cosa difficilmente spiegabile, e a suo modo meravigliosa, è come, per ognuno degli appartenenti alle (almeno) cinque diverse generazioni di Aquilani che in quel locale hanno bevuto vino e assaggiato salumi e formaggi, Ju Boss sia la cantina che appartiene alla propria epoca, che risponde ai gusti del proprio tempo. In determinate ore del giorno, entrando lì dentro, puoi divertirti a ricostruire un’immaginaria linea della storia degli ultimi ottant’anni dell’Aquila – e non solo dell’Aquila – e a posizionare ognuna delle facce che il tuo sguardo intercetta in una determinata posizione. È una sorta di luogo di iniziazione alla vita sociale urbana, che ha saputo trattenere – e forse è stato proprio questo ad averlo reso sempre attuale – le tracce di ogni epoca che ha attraversato, senza cancellarne nessuna. Tutto questo per spiegare il perché, quando nel dicembre 2009 Ju Boss riaprì dopo i lavori di ristrutturazione resi necessari dal terremoto, a L’Aquila fu una festa, una piccola Pasqua che lasciò attoniti molti ignari osservatori esterni. “È stato uno dei giorni più belli della mia vita, sicuramente il più bello dal 6 aprile ad oggi” – mi disse una mia amica che era stata presente alla nuova inaugurazione (a proposito della quale, per farsi un’idea dell’importanza che ebbe per la comunità aquilana, vale la pena di guardare questo video: “Dice che Ju Boss ha riaperto”).
Stasera però noi non andiamo al Boss. Il compleanno della nostra amica è all’aperto, proprio in piazza, dove lei offre da bere a chiunque le faccia gli auguri. Oddio, offrire da bere forse non è esattamente l’espressione più appropriata per indicare il fatto che lei ha comprato tre o quattro taniche di Montepulciano d’Abruzzo da cinque litri ciascuna, che sono fruibili da chiunque si spacci per suo amico. Del resto lei non è ormai – è l’una passata – del tutto lucida: ce ne siamo accorti da come ci ha risposto al telefono per dirci che “il brindisi” è vicino alla fontana. Cioè dalla parte opposta della piazza, per raggiungere la quale – e si tratta di non più di venti metri – impieghiamo cinque minuti. E stavolta a rallentarci non sono i saluti e gli abbracci di conoscenti persi di vista, ma una massa compatta di corpi, ondeggiante e impenetrabile come gelatina, attraverso cui fatichiamo non poco a farci largo. Finalmente troviamo la festeggiata, che è in uno stato di incoscienza misto ad esaltazione, e che ci abbraccia e ci presenta a tutti i suoi amici (scopriremo solo più tardi che molti di essi sono diventati suoi “amici” proprio quella sera stessa). Quelli che di noi non guidano bevono un bicchiere, agli altri tocca rifiutare.
Prima di tornare ognuno a casa sua, decidiamo di starcene qualche minuto tranquilli in una zona più defilata: alcuni di noi staranno via dall’Aquila per un mese o due, e dunque ci sembra opportuno salutarci in maniera degna, trovando un posto tranquillo. Scegliamo Piazza Palazzo. Solo che per arrivarci dobbiamo immergerci nuovamente nell’apnea della calca, e poi ridiscendere lungo il Corso, dove verosimilmente incontreremo le stesse facce incrociate in precedenza, quando il Corso lo abbiamo attraversato in senso opposto, e quelle facce ci lanceranno cenni di divertita rassegnazione, come a dire: gira e rigira sempre qua stiamo. Perché in effetti il centro dell’Aquila, quello che è stato davvero riaperto e che è tornato ad essere frequentato dagli Aquilani, si risolve in una via che parte dalla Fontana Luminosa e arriva fino alla Villa Comunale, un’unica direttrice cha cambia nome varie volte (Corso Vittorio Emanuele II, Corso Federico II, Viale Francesco Crispi), ma che in effetti non è altro che il cardo dell’Aquila. Ecco, tutto quello che succede il giovedì e il sabato sera a L’Aquila, succede lungo quella strada.
“Però non ti sta mai bene niente – mi rimprovera Cristina, sbuffando – L’altra sera c’era troppa poca gente; stasera ce n’è troppa. A me piace che ci sia un po’ di movimento, ed è importante che ci sia”.
È vero: è bello vedere gli Aquilani tornare ad impossessarsi della loro città. Come un fiume indomito che preme sugli argini e, ogni volta che questi vengono rotti, si riversa negli spazi circostanti, così all’Aquila le persone tendono ad occupare quanto più suolo urbano possibile, a mano a mano che le transenne spariscono e la zona rossa viene ridotta. Ed è per certi versi commovente la voglia che la gente dimostra di riprendersi vicoli e piazze, di ritagliarsi, in uno scenario di surreale disorientamento, piccoli brandelli di normalità. Eppure in quell’ostinata ricerca di un divertimento posticcio che possa disperatamente opporsi alla desolazione, in quella movida assurda in mezzo allo squallore, c’è una rassegnata dichiarazione di impotenza, una definitiva ammissione di sconfitta. Te ne accorgi allontanandoti di appena pochi passi dal centro dell’esaltazione, quando di colpo tutto svanisce e il buio e il silenzio tornano a divorarsi ogni cosa, a ricordare che quella è la realtà. Ed è per questo che ti rendi conto di come di spontaneo, nell’aggirarsi allucinato tra palazzi puntellati e cumuli di macerie ai bordi delle strade, con i bicchieri pieni di mojito in mano e dei sorrisi immateriali sul viso, mentre un’assordante musica elettronica fa esplodere l’aria, non c’è nulla: ogni gesto denuncia un’artificiosità pietosa. Improvvisamente penso che si tratta di un qualcosa che non è poi molto diverso da certi riti pagani grossolanamente sgrezzati dal cristianesimo: per una di quelle bizzarre associazioni di immagini, lontanissime tra loro, che la mente realizza a volte quando il vino o il sonno la intorpidiscono, mentre cammino per le vie dell’Aquila in un sabato sera d’estate, mi tornano alla memoria i tarantati descritti da Ernesto De Martino ne La terra del rimorso: proprio come i contadini salentini che attribuivano al pizzico della tarantola l’origine del loro malessere, così da poter dare a quella sofferenza dei connotati conosciuti ed accettabili, e poterla poi sfogare, secondo le convenzioni sociali, nel ballo animalesco, allo stesso modo tanti Aquilani vagano per le vie del centro, in giorni ed orari prestabiliti, alla ricerca di una catarsi da un tormento indecifrabile, attraverso atti che apparirebbero bestiali, se non fossero da tutti perpetrati come norma.
È un qualcosa che forse non avviene solo a L’Aquila. Ma che certo, proprio perché qui lo sfacelo circostante rende più tremenda l’insensatezza dello sballo, a L’Aquila diventa più evidente.
[1] Subito dopo il terremoto, molti sfollati furono alloggiati nelle tendopoli o negli alberghi sul litorale abruzzese. Altri trovarono rifugio presso parenti o amici fuori città; per questo, molto di frequente, ci si sentiva chiedere “Dove vi hanno mandati?” e, di conseguenza, quanto tempo si prevedeva di passare in quelle sistemazioni provvisorie. Man mano che i pochi fortunati cominciarono a tornare nelle proprie case rimaste illese la notte del 6 aprile, si cominciò a chiedersi reciprocamente se si fosse “rientrati”. Chiedendo “quale lettera si fosse ricevuto”, infine, si intendeva domandare a quanto ammontasse il danno subito dalle rispettive abitazioni secondo le perizie eseguite dai tecnici del Comune o della Protezione Civile, che assegnavano a ciascuna casa una lettera corrispondente al grado di gravità delle lesioni, in una scala che andava, perlopiù, da un minimo “A = nessun danno strutturale” a “E = edificio da abbattere”.
Leggi anche la prima parte e la seconda parte.
di Valerio Valentini, da quattrocentoquattro.com
http://quattrocentoquattro.com/2013/08/05/vivere-e-raccontare-laquila-giugno-2013-terza-parte/
quest’opera è sotto licenza Creative Commons






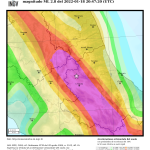


















 6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.