di Valerio Valentini – “Icetecelo a quiji de fore, quanno se ‘nne rejete”, mi investe alle spalle una voce rude, ma priva di qualunque scortesia. Resto titubante per qualche secondo, e mi accorgo che la mia posa deve risultare un po’ cretina: fermo, con le mani nelle tasche della felpa, le gambe leggermente divaricate, gli occhi in alto a guardare i cornicioni sgretolati di un palazzo all’imbocco di Via Sallustio. Mi illudo che, prolungando per qualche attimo ancora la mia immobilità, quella presenza misteriosa che deve essere un paio di metri dietro di me possa dissolversi, e che con essa svanisca il mio imbarazzo di non sapere cosa rispondere, se abbozzare un sorriso e proseguire oppure chiarire l’equivoco che ho intuito in quelle sue parole. O forse dovrei attendere – speranza vana, dal momento che nella mezzora che ho già trascorso in questa via, l’unica cosa viva che ho visto muoversi è stato un gatto – che sia l’intromissione di una terza persona a riscuotere quella strana sospensione del tempo? “Icetecelo come sta L’Aquila. Essola com’è: ar’e ji miracoli che dice la televisiò”. E così l’equivoco mi si rivela evidente, e subito mi convinco che non mi serve voltarmi per capire chi è che sta parlando, quasi riuscissi a percepire non solo la provenienza e l’età di quella presenza, ma anche i contorni del suo viso, le sue mani ruvide e spesse, la sua statura robusta.

Foto: da “L’Aquila ferita” di Federico Montaldo
Quando finalmente ruoto su me stesso, mantenendo – me ne rendo immediatamente conto, e non sono sicuro di riuscire a correggerla – la stessa espressione stordita sul mio viso, resto in parte sorpreso. La voce che ha interrotto la mia desolata contemplazione serale appartiene a un uomo sulla quarantina, abbastanza snello, più alto di me di parecchi centimetri. Gli avrei dato come minimo dieci anni in più, a quella voce, forse anche venti: l’avrei detta una voce anziana, consumata. C’era, nella sua cadenza, una certa rassegnata stanchezza. Invece l’uomo che ho davanti – da quanti secondi, ormai, se ne resta lì impalato, anche lui, cretino almeno quanto me? – lo si direbbe un impiegato di banca che sta raggiungendo gli amici in pizzeria, o un padre che ha appena accompagnato suo figlio ad una festa. Dovrei dirgli che si sta sbagliando, che io non sono “uno di fuori”, che non ho creduto a nessun miracolo della televisione, che la situazione in cui si trova L’Aquila la conosco bene anch’io, ché io a L’Aquila ci sono nato e cresciuto. Invece, semplicemente, abbasso gli occhi, lascio uscire dai denti semichiusi uno strascicato “Va bene, arrivederci” e riprendo a camminare, risalendo lungo il selciato sconnesso.
Ci metto una manciata di secondi per smaltire un illogico senso di disagio, dopodiché le parole che quell’uomo mi ha rivolto mi ritornano chiare e familiari, in fondo potrei essere stato io stesso a pronunciarle; mi ricordano dell’ansia che da quattro anni appartiene ad ogni aquilano: l’ansia di raccontare la tragedia della propria città. Un’ansia che deve sollecitare chiunque subisca un trauma, visto che raccontare la realtà, soprattutto quando questa è drammatica, è forse il modo migliore per scenderci a patti; ma quella degli Aquilani è un’ansia diversa, figlia più della paura d’essere dimenticati, d’essere abbandonati, che non della necessità di razionalizzare il dolore. Un’ansia che nel tempo si è fatta tanto più pressante quanto più, vivendo a L’Aquila, vedendo come dell’Aquila si parlava nei media, si percepiva che nell’immaginario collettivo si andava affermando l’illusione secondo cui tutto, o quasi, fosse stato risolto, ché i danni causati dal terremoto erano stati enormi, è vero, ma comunque l’emergenza era terminata, e la situazione stava lentamente, pur se tra molti ostacoli, tornando alla normalità.
Così succede che guardi i talk show in cui si elencano dettagliatamente “le urgenze del Paese”, e L’Aquila non viene nominata; leggi le dichiarazioni del presidente del consiglio sull’imminente varo della finanziaria “per rilanciare l’economia del Paese”, e alla situazione dell’Aquila non si fa alcun cenno; ascolti il ministro dei beni culturali discettare della necessità di valorizzare il patrimonio artistico, “vera risorsa del Paese”, e neppure una parola sullo strazio del centro storico dell’Aquila. E subito, insieme alla rabbia, avverti il bisogno di denunciare, di spiegare, di rendere partecipi.
Ma più ancora che nell’ignoranza di ministri e giornalisti, la totale mancanza di cognizione della tragedia dell’Aquila la cogli nelle parole e nei volti delle persone che incontri in giro per l’Italia, quando ti chiedono “Vanno meglio, lì, le cose?” con l’aria di chi ammette che possa esserci più di una risposta possibile a questa domanda. Il che, forse, ti risparmia la sgradevole visione di una compassione posticcia, ma ti costringe ad accorgerti di quanto presto si infranga l’eco del dolore della tua città appena oltre i confini provinciali. E ti richiama, ogni volta, ad un confuso dovere civile: raccontare.
Solo che raccontare la situazione dell’Aquila, o anche solo fornirne un resoconto che dia vagamente la misura della tragedia, è quanto mai complicato. Perché per far sì che chi non è mai stato a L’Aquila si faccia un’idea della drammaticità delle condizioni in cui la città vive, bisognerebbe riuscire a fornire un quadro completo dello sfacelo, ché solo se colta nella sua totalità, in tutti i suoi risvolti, l’assurdità di quello sfacelo può essere capita. Ma difficilmente ci si riesce: e allora di solito ti affidi a singole immagini, ti sforzi di raccogliere tra le quotidiane visioni del fradiciume – che ormai, ed è tremendo, comincia a farsi abitudine, e quindi a perdere, ai tuoi occhi, qualunque significatività – qualche scorcio che possa essere emblematico, che sintetizzi l’agonia, la stagnazione, la paralisi. E allora racconti, quando vuoi far capire che l’espressione “L’Aquila è ferma alla notte del 6 Aprile 2009” non è soltanto uno slogan, che in alcune pompe di benzina della città la verde costa 1.097 Euro al litro, il gasolio 1.047; che al cinema “Massimo”, il più importante del centro, danno “Gli amici del Bar Margherita”, l’ultimo imperdibile film di Pupi Avati; che in molte vetrine delle vie principali si annunciano sconti fantastici in vista della settimana santa. Oppure, per testimoniare di come il degrado stia divorando la città, parli della più bella scalinata del centro storico che è ormai ricoperta di muschio ed erbacce, o del puzzo di carogna che appesta i vicoli dietro a quello che era il tuo liceo.
Ma raccontare la situazione dell’Aquila è difficile anche dal punto di vista linguistico. Usiamo comunemente un vocabolario, che è soprattutto il vocabolario giornalistico, impestato di iperboli, di esagerazioni retoriche, di stucchevole strappalacrimismo. E dunque quando davvero senti il bisogno di ricorrere ad espressioni forti, per descrivere qualcosa di straordinario, te le ritrovi inservibili, sfibrate. È per questo che le parole che ho utilizzato finora, e che mi vedo costretto ad utilizzare, mi suonano ridicole, patetiche, quasi offensive rispetto alla realtà del dolore. Tragedia, dramma, sfacelo: quante volte le abbiamo ascoltate in riferimento ad una partita di calcio, ad un’improvvisa innalzata della spread, alla corruzione diffusa nelle istituzioni? Come fai a far capire che quelle parole, che tu usi per descrivere la sofferenza di decine di migliaia di persone, il decadimento di un’intera città, dovrebbero essere recepite nel loro significato autentico? Non ce la fai, semplicemente. E così ti senti inibito, incapace di comunicare.
Proprio da questa incapacità, forse, nasce un altro sentimento che è piuttosto diffuso negli Aquilani: il desiderio di portare all’Aquila quante più persone possibili. Decine di miei amici, se solo potessero, organizzerebbero quotidianamente viaggi in pullman da ogni parte d’Italia con destinazione L’Aquila, per sentirsi finalmente sollevati dal dovere scomodo di raccontare, e per lasciare che a parlare siano le macerie e i puntelli. Scaraventare uomini e donne ignari dello squallore in mezzo ad una realtà così desolata, sarebbe effettivamente l’unica soluzione per dare un’immagine esauriente da memorizzare: qualunque mediazione narrativa rischia di falsare e distorcere. Ma a cosa servirebbe, in definitiva, scagliare questo squallore in faccia a milioni di spettatori?
Tutte le volte in cui mi è capitato di mostrare L’Aquila ad amici e conoscenti, dopo il terremoto, sgattaiolando tra le transenne della zona rossa, mi trovavo di fronte ad una forma diversa, ma per certi versi analoga a quella descritta prima, di incomunicabilità. Mi rendevo conto che ciò che quelle macerie dicevano a me era infinitamente diverso rispetto a quello che dicevano a chi mi stava a fianco. E questa è un’ovvietà, naturalmente, che però sottende una verità meno banale: e cioè che i visitatori, non riuscendo a cogliere, se non vagamente, la sofferenza umana che quelle macerie urlano, restano soltanto abbagliati, o al limite nauseati, da un panorama di devastazione così impressionante. Una mia compagna di università, dopo aver visitato L’Aquila, facendo un resoconto di quello che aveva visto utilizzò la parola “spettacolo”. Non ricordo, e probabilmente neppure l’ascoltai, l’aggettivo che lei accompagnò a questa parola: per me quello “spettacolo” pronunciato con quella che a me sembrava una leggerezza oltraggiosa, fu insopportabile. Non le dissi nulla, ma non le parlai per un paio di giorni: poi realizzai che non era stata una freddezza sadica a generare quel suo giudizio, ma un’umanissima meraviglia. L’Aquila, a chi non abbia mai visto una città bombardata, è effettivamente uno spettacolo.
Qualcosa di non troppo diverso da Pompei (non a caso il paragone è stato fatto più volte in questi anni, sia da chi voleva lanciare un allarme inquietante sia da chi ricercava macabri espedienti per incentivare il turismo): e del resto nessuno, oggi, troverebbe disdicevole definire Pompei “uno spettacolo”, perché di quella che fu la sofferenza degli uomini e delle donne che restarono carbonizzati sotto la lava, o intossicati dalle polveri del Vesuvio, noi passeggiando per Pompei non percepiamo che qualche sparuto frammento. Visitando L’Aquila accade qualcosa di simile. Ora, fare paragoni è impossibile: non so quanto tempo passò prima che i Romani smettessero di considerare quello che avvenne nel 79 d.C. una “tragedia” e cominciassero a rimanere estasiati davanti allo “spettacolo” della Pompei fossilizzata; credo però che questo processo stia avvenendo, per quanto riguarda L’Aquila, ad una velocità pazzesca. Probabilmente il motivo risiede nel fatto che siamo ormai immersi in un perpetuo presente: obbligati a restare aggiornati su quello che avviene ogni giorno in giro per il mondo, tendiamo inevitabilmente a liberarci di tutto ciò che è “passato” come di un macigno che ci rallenta nella corsa alle ultimissime. Un evento accaduto quattro anni fa sembra appartenere ad un’era quanto mai remota, di cui non conserviamo che una sbiadita memoria. E allora quello che colpisce, a L’Aquila, oltre allo spettacolo della catastrofe, è lo spettacolo di poter rivivere una porzione di Italia cristallizzata all’aprile 2009: quanto costava la benzina allora? Quali film c’erano nelle sale cinematografiche? E poi, soprattutto, c’è la voglia di avvicinarsi a ciò che, in vario modo, è divenuto storia, di riscattare la propria anonima esistenza di individui immortalandosi vicino a qualcosa di cui hanno parlato le televisioni, e di cui magari in futuro ci si ricorderà. L’Aquila e l’Isola del Giglio, la Casa dello Studente e la Costa Concordia, in questo senso, sono molto vicine.
Tutto ciò chi vive a L’Aquila lo avverte chiaramente, anche se in maniera istintiva. L’incolmabile distanza tra il muoversi stupito e impacciato di chi cerca lo scorcio migliore da fotografare, l’angolo più eloquente in cui cogliere la sciagura, e la perizia di chi ormai scavalca con collaudata automaticità intoppi e deviazioni, assuefatto e quasi insensibile alla bruttezza, si rivela immediatamente. Forse è proprio questo il motivo per cui quell’uomo che poco fa mi ha scambiato per un turista del macabro mi ha tanto infastidito: è come se mi avesse rimproverato il mio sradicamento, il mio vivere lontano dall’Aquila per nove mesi l’anno.
Perché il modo in cui gli Aquilani si relazionano con “quelli di fuori” è piuttosto contraddittorio: vorrebbero che tutt’Italia fosse testimone del disfacimento a cui è stata condannata la propria città, ma allo stesso tempo sopportano con malcelata diffidenza di vedersi invasi in un qualcosa di estremamente privato. Una diffidenza che è certamente il residuo del disgusto provocato dalle tante, troppe passerelle in cui, salvo rarissime occasioni (le iniziative di Libera, la convocazione degli storici dell’arte ad opera di Tomaso Montanari, e poche altre) si sono risolte le visite di politici, ministri, architetti di grido e personaggi dello spettacolo. Però c’è anche dell’altro, qualcosa di più personale, di più epidermico. C’è uno spontaneo senso del pudore: nel mostrare le viscere dei propri palazzi a degli sconosciuti, ci si scopre nudi e impotenti. Per capirlo ti basta parlare con i tuoi amici che avevano la casa nelle vie principali del centro, quelle che, in parte, sono state riaperte: non amano passarci davanti in compagnia di altri, e anzi vivono con disagio il fatto che chiunque, camminando per strada e alzando gli occhi, possa intrufolarsi con lo sguardo nelle camere, nei bagni, nelle cucine in cui loro hanno vissuto per anni, in un’intimità famigliare che viene violata ogni volta che, attraverso gli squarci alle pareti, o le tamponature e i tramezzi crollati, un passante scorge un quadro, un poster, un accappatoio, uno scaldabagno.
leggi anche la seconda parte e la terza parte
di Valerio Valentini, da quattrocentoquattro.com
http://quattrocentoquattro.com/2013/07/18/vivere-e-raccontare-laquila-giugno-2013-prima-parte/
quest’opera è sotto licenza Creative Commons






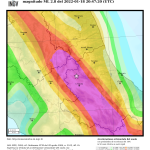










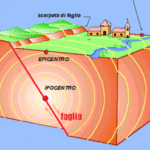
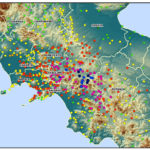
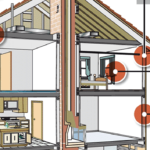




 6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.