Il centro del capoluogo abruzzese è una città fantasma, la gente vive in agglomerati anonimi e asettici, le relazioni sociali sono andate in pezzi. Il trauma collettivo continua. Un reportage di Mente&Cervello segnala la sempre maggiore diffusione delle patologie psichiche.
 da Repubblica.it – Hanno perso familiari e amici. Non hanno più la loro casa e il cuore della loro città è ancora in rovina. Non trovano luoghi nei quali incontrarsi e le relazioni sociali sono completamente disgregate. Vivono in agglomerati anonimi e asettici, nei quali è impossibile recuperare la propria identità. A pochi giorni dal quarto anniversario del sisma, che il 6 aprile 2009 devastò L’Aquila e molti comuni vicini, i cittadini del capoluogo abruzzese continuano a vivere un tempo “dissestato, sconnesso, una vita fuori sincrono in cui tutto è diviso tra prima e dopo il sisma, senza possibilità di progettualità”.
da Repubblica.it – Hanno perso familiari e amici. Non hanno più la loro casa e il cuore della loro città è ancora in rovina. Non trovano luoghi nei quali incontrarsi e le relazioni sociali sono completamente disgregate. Vivono in agglomerati anonimi e asettici, nei quali è impossibile recuperare la propria identità. A pochi giorni dal quarto anniversario del sisma, che il 6 aprile 2009 devastò L’Aquila e molti comuni vicini, i cittadini del capoluogo abruzzese continuano a vivere un tempo “dissestato, sconnesso, una vita fuori sincrono in cui tutto è diviso tra prima e dopo il sisma, senza possibilità di progettualità”.
Sintomi di un trauma collettivo, che ha lasciato segni profondi durante la scossa, ma soprattutto nel periodo successivo, e i cui effetti ancora evidenti sono una “depressione fuori controllo e la diffusione di patologie mentali in costante aumento”. Una condizione che, stando a quanto scrive Ranieri Salvadorini nel reportage di copertina del prossimo numero di Mente&Cervello, è tangibile in una popolazione prima spaventata, poi disorientata e infine offesa e che ora, nonostante il passare del tempo, fatica a ritrovare se stessa.
|
Il caos e il dolore. Difficilissimi i primi giorni dopo il sisma, scrive Salvadorini, con la gestione dell’emergenza completamente affidata alla Protezione civile. Il clima teso si respirava soprattutto nelle tendopoli dove gli psicologi del Dipartimento salute mentale dell’Aquila hanno dovuto lottare non poco per ‘ritagliarsi’ degli spazi per continuare a seguire le persone che avevano in cura prima del terremoto e per fornire assistenza ai nuovi traumatizzati. Al dolore per la perdita degli affetti e delle case, in quei giorni si è unita la percezione di una sorta di ‘costrizione’ anche negli aiuti. “Certi interventi sono stati più subiti che ricevuti dagli aquilani”, dice uno degli intervistati. “Ogni passaggio della gestione della vicenda aquilana è accompagnato dalla figura del militare, che all’Aquila è stata vissuta molto male”. Una gestione, probabilmente, troppo rigida che, per chi sentiva di aver perso tutto, ha significato la perdita anche della libertà. |
“La gestione militarizzata dei campi – si legge nell’articolo – tesa a garantire efficienza, controllo e sicurezza, oltre che i bisogni primari, sembra aver contribuito ad aprire quel solco di depersonalizzazione che ha avuto come esito una popolazione in larga parte ‘obnubilata’, presente e al tempo stesso assente”.
Trauma su trauma. Agli aquilani è mancata, secondo gli psicologi intervistati, la possibilità di prendere coscienza dell’accaduto e di assumersi le responsabilità di ripartire. “Le persone non hanno fatto in tempo a rendersi conto di cosa fosse successo loro che sono state deportate nei campi o negli alberghi, dove era tutto organizzato: pranzo, cena, dentifricio, lenzuola. Mentre era chiaro che, a un certo punto, la gestione dei campi sarebbe dovuta andare in mano agli aquilani”. Ed è esilio, purtroppo, una delle parole (forti) che gli psicologi hanno sentito pronunciare nel corso delle terapie: un concetto difficile da comprendere per chi ha visto la vicenda da fuori e, probabilmente, non capisce come gli ‘aiuti’ possano essere percepiti così. “Chi rimane ferito, la deve vedere la sua ferita – spiega uno degli esperti intervistati; è vero che tu mi medichi, ma io ho bisogno di vedere cosa mi sono fatto. E mi voglio lamentare del mio dolore, perché il primo momento dell’elaborazione avviene attraverso la catarsi”. Questo, però, agli aquilani è stato impedito. La rete sociale si è disgregata e, soprattutto nei primi giorni, persone sconosciute si sono trovate a condividere la stessa tenda (anche in otto). E poi, da un campo all’altro, da un campo a un modulo abitativo provvisorio (map) o a un appartamento del progetto C. a. s. e. “A ogni sgombero c’era un nuovo trauma, specie dove si era riusciti a costruire un po’ di senso di comunità”.
La lunga lista dei divieti. Senz’altro legati alla necessità di mantenere l’ordine e la sicurezza, soprattutto in un momento in cui la confusione era totale, i numerosi divieti dettati all’interno delle tendopoli non hanno certo reso più semplice la sopportazione del dolore. “Il divieto di fare visita ai propri cari se sprovvisti di documento d’identità, il divieto di fare assemblee o di ritrovarsi, il divieto di volantinaggio, il divieto di distribuire caffè, Coca cola, alcool o altre sostanze eccitanti, il divieto di fare visita oltre un certo orario (di solito le 21)…”. E a quanto viene riferito nell’articolo, c’era anche un divieto prefettizio ai giornali di parlare dei suicidi, per evitare che si creasse panico.
Le macerie dell’anima. Un’impennata dei casi di depressione e tantissime persone che, pur non manifestando sintomi gravi della patologia, mostrano segni di malessere. I dati raccolti per una ricerca dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, spiega Salvadorini, rivelano che il 60-70% della popolazione aquilana è stata colpita dalla depressione, mentre tantissimi, pur non manifestando segni evidenti, mostrano “sintomi depressivi di lieve e medio grado di sofferenza, di nostalgie e di scarse speranze per il futuro”. Non c’è più vita sociale e le occasioni di aggregazione sono difficilissime da creare.
Lo schiaffo mediatico. E se non bastava già tutto questo dolore, i terremotati hanno dovuto fare i conti anche con la rappresentazione distorta degli eventi, con le false promesse dei politici e con la negazione della sofferenza che, al contrario, loro sentivano fortissima. “Quando in certe trasmissioni si sentiva dire che gli aquilani stavano bene, molti vivevano l’ingiustizia di vedere negato il proprio disagio concreto… molte persone si sono sentite violentate nella propria sofferenza”. E ora, oltre alle case, c’è bisogno di ricostruire molto di più: la fiducia nel domani e in quel tessuto sociale che significava essere parte di una comunità.
di Piera Matteucci, da Repubblica.it























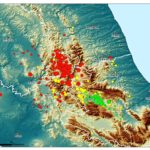
 6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.