 Dal Corriere.it del 4 ottobre 2010, di Sergio Rizzo (“I professionisti delle macerie”)
Dal Corriere.it del 4 ottobre 2010, di Sergio Rizzo (“I professionisti delle macerie”)
La ricostruzione in Friuli e’ stata portata a termine perché gli aiuti sono stati gestiti dai locali. Il Sud invece e’ rimasto “terremotato”. Ma ovunque c’e’ chi ha fatto enormi affari. Forse per circa 140 miliardi di euro, dal 1968. L’Aquila esclusa
«Qui bisogna partire in quarta subito. Non e’ che c’e’ un terremoto al giorno», dice al telefono il 6 aprile 2009 il costruttore Pierfrancesco Gagliardi a suo cognato, Francesco Maria De Vito Piscicelli, l’uomo passato alla storia per aver confessato, nel corso di quella intercettazione: «Io ridevo stamattina alle tre e mezzo dentro il letto». Mentre a L’Aquila 300 persone, fra cui 20 bambini, morivano sotto le macerie.
«Non e’ che c’e’ un terremoto al giorno» e’ la frase chiave per spiegare quello che succede in Italia quando c’e’ una grande calamita’ naturale. Di terremoti non ce n’e’, per fortuna, uno al giorno, ma uno ogni qualche anno purtroppo sì. Senza contare le frane, le alluvioni, gli smottamenti: eventi nei quali c’e’ sempre lo zampino dell’uomo. Gia’ nel 1884 la commissione d’inchiesta sulla situazione dell’agricoltura presieduta da Stefano Jacini denunciava i rischi per l’assetto idrogeologico del disboscamento selvaggio in atto ormai da anni in Italia. Da allora si e’ andati di male in peggio. Oppure in meglio, secondo i punti di vista. Perché una cosa almeno e’ certa: calamita’ naturale significa sempre grandi business. Se poi la calamita’ in questione e’ un terremoto, allora la pacchia per affaristi e politici e’ assicurata. Ci sono le eccezioni, e’ vero. Come gli esempi di abnegazione e solidarieta’ che fanno onore al Paese: l’impegno dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, ma anche di amministratori locali che si prodigano fino al sacrificio per la comunita’. È successo nel Belice, in Friuli, in Irpinia, in Umbria e nelle Marche, all’Aquila… Ma quando la macchina dei soccorsi si e’ fermata e si sono fatti i conti, beh, la musica e’ cambiata. Nessuno e’ in grado di dire esattamente quale giro d’affari abbiano messo in moto i terremoti dal 1968, anno del sisma nel Belice, a oggi. Ma una valutazione di 140 miliardi di euro non e’ irrealistica. E senza considerare il costo del terremoto dell’Abruzzo, che il direttore del commissariato per la ricostruzione Gaetano Fontana stima in 10 miliardi e mezzo di euro per la sola L’Aquila.
E sarebbero stati soldi benedetti: con quei denari non soltanto si potevano ricostruire le abitazioni, le chiese e le opere pubbliche distrutte. Ma anche rilanciare economie depresse. Invece il diluvio di quattrini, salvo qualche caso, e’ scivolato via come l’acqua sull’asfalto. È un dato di fatto, per esempio, che l’enorme massa di contributi pubblici arrivata al Sud dopo il terremoto dell’Irpinia non ha ridotto il divario fra le regioni che furono beneficiate dei finanziamenti statali e il Nord. Così, se il terremoto del Friuli, forse l’unica eccezione positiva al punto da essere presa ancora oggi a modello, ci ha lasciato in eredita’ la Protezione civile (nacque lì), decine di citta’ rimesse a nuovo e un tessuto produttivo sano, il sisma dell’Irpinia ha regalato agli italiani una massa di debito pubblico pari ad almeno quattro punti di Pil. Vero e’ che sul prezzo della benzina ancora oggi gravano 99 lire di accisa per il terremoto friulano contro le 75 lire assegnate a quello irpino.
Ma fa drizzare i capelli in testa il numero che c’e’ in fondo a una relazione della Corte dei conti stilata nell’estate del 2008 da Anna Maria Carbone Prosperetti: 32 miliardi 363 milioni 593.779 euro. Versati nel calderone del terremoto irpino. Ed e’ un numero che non dice nemmeno tutto, perché attualizzandola al 2010 quella cifra supererebbe di slancio i 66 miliardi di euro. Da tre a sette volte i denari che sarebbero stati spesi in Friuli-Venezia Giulia. Un diluvio universale, proseguito ininterrottamente per tre decenni, con 27 diversi provvedimenti approvati in 28 anni. Una media di una legge l’anno. L’ultimo stanziamento in ordine di tempo risale alla fine del 2006: 157 milioni e mezzo. Da spendere, udite udite, in 15 anni, fino al 2021 compreso! Ma i soldi sono rimasti inutilizzati per oltre un anno e mezzo perché al governo si erano “dimenticati” di fare il regolamento per farli uscire dal cassetto. Basti dire che il numero dei paesi terremotati, inizialmente qualche decina, e’ stato portato via via con leggi e norme varie a 687. Cioe’ l’8,5 per cento di tutti i comuni italiani. Quattro volte e mezzo quelli compresi nell’area terremotata del Friuli.
Un cratere enorme nel quale, manco a dirlo, finì anche Napoli. Con risvolti da brivido, se si pensa che lì il costo medio di un’abitazione compresa nel piano di ricostruzione delle zone urbane “danneggiate” dal sisma superò abbondantemente il miliardo di lire, contro i 30 milioni del Friuli. Certo, anche in Irpinia si pensò a rilanciare l’economia, come in Friuli, il cui modello di ricostruzione prevedeva queste priorita’: fabbriche, chiese e poi case. Soltanto, in un modo che più sbagliato non si poteva: innestando attivita’ industriali super incentivate in un territorio dove l’industria non c’era mai stata. Non fosse bastata l’esperienza anche nefasta della Cassa del Mezzogiorno, i risultati furono disastrosi: scandali e ruberie a ripetizione. Molte imprese nascevano e fallivano, con l’unico obiettivo di intascare i soldi pubblici. E inevitabili strascichi giudiziari, che hanno fatto guadagnare soprattutto gli avvocati. Caso emblematico, nella primavera del 2009 la Corte dei conti ha emesso una condanna al pagamento di un danno erariale di 6 milioni di euro nei confronti del consorzio che aveva concesso lauti contributi alla Castelruggiano per aprire uno stabilimento di vini confezionati nell’area di Oliveto Citra (Salerno). Una fabbrica dalla quale «per una serie complessa di vicende culminate con il fallimento» come scrivono i magistrati contabili, non e’ mai uscito un litro di vino.
A un certo punto, poi, i soldi arrivavano tanto copiosamente che non si riuscivano nemmeno a spendere. E finivano in banca, alimentando un fenomeno incredibile: prestiti alle imprese del Nord. Nell’Irpinia si verificò addirittura un evento soprannaturale con la nascita nel cratere del sisma, in appena sette anni, di ben 26 banche cooperative. Nove solo nella provincia di Avellino. Per le famose 20 zone industriali disseminate fra Campania e Basilicata e i contributi alle aziende si spesero 7.762 miliardi di lire (8 miliardi di euro oggi). Meta’, 3.488 miliardi di lire, venne impiegata soltanto per la realizzazione delle infrastrutture. E la spesa alla fine risultò, ha calcolato la Corte dei conti, ben 11 volte più grande della previsione iniziale di 313,3 miliardi. Il costo per le aree industriali in provincia di Avellino fu 12 volte superiore alla stima iniziale, quello per le aree del salernitano addirittura 17. Per rendersi conto del fallimento di questa operazione, per il quale nessuno, va sottolineato, ha pagato politicamente, basta leggere le conclusioni della relazione della magistratura contabile datata 15 dicembre 2000. Non bastò la lievitazione dei costi per le infrastrutture, cresciuti in alcuni casi, scrissero i magistrati, «di circa 27 volte rispetto a quelli previsti nelle convenzioni originarie». I controlli portarono poi a ben 164 revoche di concessioni di lotti industriali: il 48,5 per cento del totale, quasi meta’. La Corte dei conti puntò il dito contro «la superficialita’ degli accertamenti e l’assenza di idonee verifiche», colpevoli di non aver fatto «adeguatamente ponderare situazioni imprenditoriali gia’ fragili e gia’ originariamente minate per scarsa professionalita’ o nelle quali la sopravvalutazione dell’investimento, in relazione alle capacita’ imprenditoriali, ha portato al fallimento dell’iniziativa».
Altre parole per dire che il clientelismo la fece da padrone. Quando quella relazione fu stesa ben 76 aziende avevano gia’ dichiarato bancarotta. Molti di quelli che avevano preso i soldi, intanto, erano gia’ scappati con la cassa, come dimostra il fatto che appena il 21 per cento dei finanziamenti revocati nella provincia di Salerno era stato recuperato. L’avessero davvero applicato in Irpinia, quel “modello Friuli” che a ogni terremoto, a ogni alluvione, a ogni frana di questo dissestato Paese i politici non si stancano di invocare. Lo ripetono, come una specie di disco rotto, da destra e da sinistra. E pensare che gia’ 300 anni fa i friulani erano stati presi a esempio per una calamita’. Accadde dopo il terremoto che nel 1693 devastò la valle di Noto e causò almeno 60mila morti, ovvero un quinto della popolazione delle zone colpite, e rase al suolo 25 localita’. Fra queste, Occhiola’, feudo di Carlo Maria Carafa Branciforti, principe di Butera, marchese di Castelvetrano e principe di Roccella, che decise di spostare il centro abitato, interamente distrutto, a un paio di chilometri di distanza. Il nuovo paese si sarebbe poi chiamato Grammichele, come ancora oggi e’ conosciuto, e venne realizzato su un modello urbanistico friulano: la fortezza di Palmanova, costruita giusto un secolo prima, nel 1593, dai veneziani a un tiro di schioppo da Udine, 1.470 chilometri più a nord. Autore di questa singolare interpretazione ante litteram del modello Friuli fu Carlos de Grunembergh, ingegnere militare olandese che il commissario generale per le zone terremotate aveva voluto accanto a sé per la ricostruzione. C’e’ da dire che Giuseppe Lanza, duca di Camastra – questo il nome del delegato del viceré di Spagna per il sisma –, aveva poteri ben diversi da quelli, pure ampi, del suo omologo Giuseppe Zamberletti che quasi tre secoli più tardi, nel maggio del 1976, il governo italiano avrebbe incaricato di gestire l’emergenza in Friuli- Venezia Giulia. Al duca di Camastra erano state attribuite prerogative praticamente illimitate, come quella di trasferire di chilometri intere citta’. Come, appunto, Noto. Tutte le decisioni erano prese centralmente, senza che le comunita’ locali fossero minimamente coinvolte: l’esatto contrario del modello Friuli. In comune, i due terremoti ebbero soltanto la violenza. Una violenza sorda e inusitata. Che in Friuli risultò anche imprevedibile: a settembre, quattro mesi dopo la prima scossa, l’orcolat, l’orco in dialetto friulano, tornò. Il terribile uno-due mise letteralmente in ginocchio la parte settentrionale della regione: 5.500 chilometri quadrati, dove vivevano 600mila abitanti. Il bilancio fu drammatico. I morti, 989. I senzatetto, più di 100mila. Le case distrutte, 18mila. Gli alloggi danneggiati, 75mila. Per non parlare dei danni patiti dal territorio, che vennero valutati a caldo in 500 miliardi di lire (somma equiparabile a 2,1 miliardi di euro del 2010), dalle imprese (altri 500 miliardi di lire) e dalle opere pubbliche (ancora 300 miliardi di lire). Alla fine il conto fatto dalla Regione raggiunse l’astronomica cifra di 4.500 miliardi di lire: oltre 18,5 miliardi di euro del 2010. Coinvolti 45 comuni definiti “disastrati” come Gemona e Osoppo, 40 “gravemente danneggiati” e 52 “danneggiati”: tutti fra Udine e Pordenone, più tre soli paesi della provincia di Gorizia. Ricordiamolo, quel 6 maggio del 1976. Il quinto governo Moro, l’ultimo, stava esalando il respiro finale. Le Camere erano state sciolte da cinque giorni e gia’ infuriava la campagna elettorale. Infuriava, perché il Pci di Enrico Berlinguer, forte dello straordinario successo alle europee dell’anno prima, sentiva odore di sorpasso. Indro Montanelli, che aveva appena fondato il Giornale, invitò gli italiani a votare per lo scudo crociato “turandosi il naso” pur di arginare i comunisti.
Si votò il 20 e il 21 giugno, e per la prima volta votarono alle elezioni politiche anche i diciottenni, in una situazione surreale. La diga democristiana non crollò, ma l’avanzata del Pci risultò impetuosa: 7,4 per cento, 48 seggi in più alla Camera. Mentre nel Paese il clima politico si andava incattivendo (di lì a poco sarebbe scoppiato il 1977 e sarebbe arrivata l’onda di piena del terrorismo), era partita una gara di solidarieta’ che in Italia sembra precedere sempre i grandi turbamenti sociali: come avvenne nel 1966 per l’alluvione di Firenze, appena prima del Sessantotto.
Va riconosciuto che la politica locale, mentre a Roma si balbettava, ebbe una reazione immediata. E con la sua prontezza, arrivò a condizionare la politica nazionale. Erano trascorse soltanto poche ore dalle 21.06 del 6 maggio, il momento della prima scossa, che il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in una seduta drammatica, approvò il mattino dell’8 maggio, seduta stante, un finanziamento immediato di 10 miliardi di lire: in valuta attuale, 40 milioni di euro. Vent’anni dopo a Gemona, dove l’orcolat aveva ucciso 380 persone su 11.300 abitanti, 8.500 dei quali erano rimasti senza casa, era come se non fosse successo niente. Il paese era di nuovo su da un bel pezzo, le facciate delle abitazioni pulite e senza un graffio, le attivita’ economiche marciavano a pieno ritmo. L’inviato del Corriere Luigi Offeddu la descrisse così il 14 aprile 1998, dopo che una nuova ma più lieve scossa di terremoto aveva fatto tornare per un attimo la paura: «Gruppi di turisti fotografano il Duomo e passeggiano sotto i portici di via Bini. Duomo e portici che sembrano così com’erano prima del 6 maggio 1976, ma che invece l’orcolat aveva frantumato, e che la gente ha ricostruito pezzo per pezzo secondo il procedimento chiamato anastilosi: raccogliere ogni pietra, numerarla, ricollocarla al suo posto. Ancora oggi, su alcune pietre dei portici si legge un numero. Ma quel numero, insieme a uno spezzone della chiesa della Madonna delle Grazie, e’ l’unica traccia che ricordi il passaggio dell’orco». Invece nella siciliana Gibellina, che il terremoto l’aveva subito otto anni prima, la gente stava ancora nelle baracche. E ci sarebbe rimasta ancora a lungo, certamente non per colpa sua. Per anni si e’ paragonata la vicenda del sisma del Friuli con quelle dei terremoti del Belice e dell’Irpinia per contrapporre l’operosita’ della gente friulana, capace di far fronte alle avversita’ rimboccandosi le maniche senza aspettare l’aiuto dello Stato, alla presunta “indolenza” dei meridionali. Quando la differenza, in realta’, non l’hanno fatta gli aspetti caratteriali ma piuttosto le decisioni politiche. Le stesse che consentirono a 40mila friulani, scappati sulla costa adriatica nell’inverno del 1976, di tornare entro il 31 marzo 1977 ai loro paesi in 350 villaggi prefabbricati. Buon senso e niente altro fu la molla che spinse chi fece i provvedimenti per la ricostruzione a mettere al primo punto i finanziamenti per far ripartire le aziende: 500 miliardi di lire, che diventarono il motore della ricostruzione. Perché la storia dell’uomo insegna che la collettivita’ resta viva soltanto intorno alle attivita’ economiche. Come buon senso e niente altro fu attribuire la responsabilita’ di gestire le risorse alle amministrazioni locali. Con controlli efficaci e rigorosi. Senza alcun riguardo per i furbacchioni che non rispettavano le regole antisismiche.
Di soldi dallo Stato ne arrivarono parecchi: al 31 dicembre 1995, quando le opere di ricostruzione si potevano ormai considerare pressoché concluse, il pallottoliere si fermò a 12.905 miliardi. Nove miliardi di euro del 2010. Ma anche questi sono calcoli incerti. C’e’ chi sostiene che i soldi arrivati al Friuli siano stati molti di più. Nei documenti dei consiglio regionale si parla di 13.500 miliardi dell’epoca. Alla Camera, nel 1996, arrivò invece una stima di 29mila miliardi, oggi una ventina di miliardi di euro. Comunque sia, i friulani ci misero la loro forza e il loro cuore. Ma siamo proprio sicuri che non si sarebbero ottenuti identici risultati in Belice e Irpinia semplicemente non trattando quelle popolazioni da “terremotati del Sud”, per usare le parole di Giusi Pitari, una delle animatrici del “movimento delle carriole” all’Aquila? Se la politica avesse usato il buon senso, la ferita del Belice sarebbe aperta ancora oggi a 42 anni da quei giorni terribili? La chiesa madre di Gibellina avrebbe aspettato fino al marzo 2010 per essere inaugurata, dopo essere crollata nel 1994, a costruzione ultimata? E resterebbe ancora da risolvere il problema drammatico dell’amianto dei tetti delle baraccopoli, che bisogna spedire in Germania perché in Sicilia nessuno sa dove smaltirlo? Ci sarebbero, quarant’anni dopo, interi quartieri senza fogne, strade in terra battuta, vie senza lampioni? I sindaci hanno fatto i conti: servirebbero ancora 370 milioni di euro. Per la Cricca li hanno trovati. Per porre fine allo strazio del Belice, no.


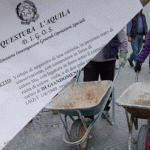




















 6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.